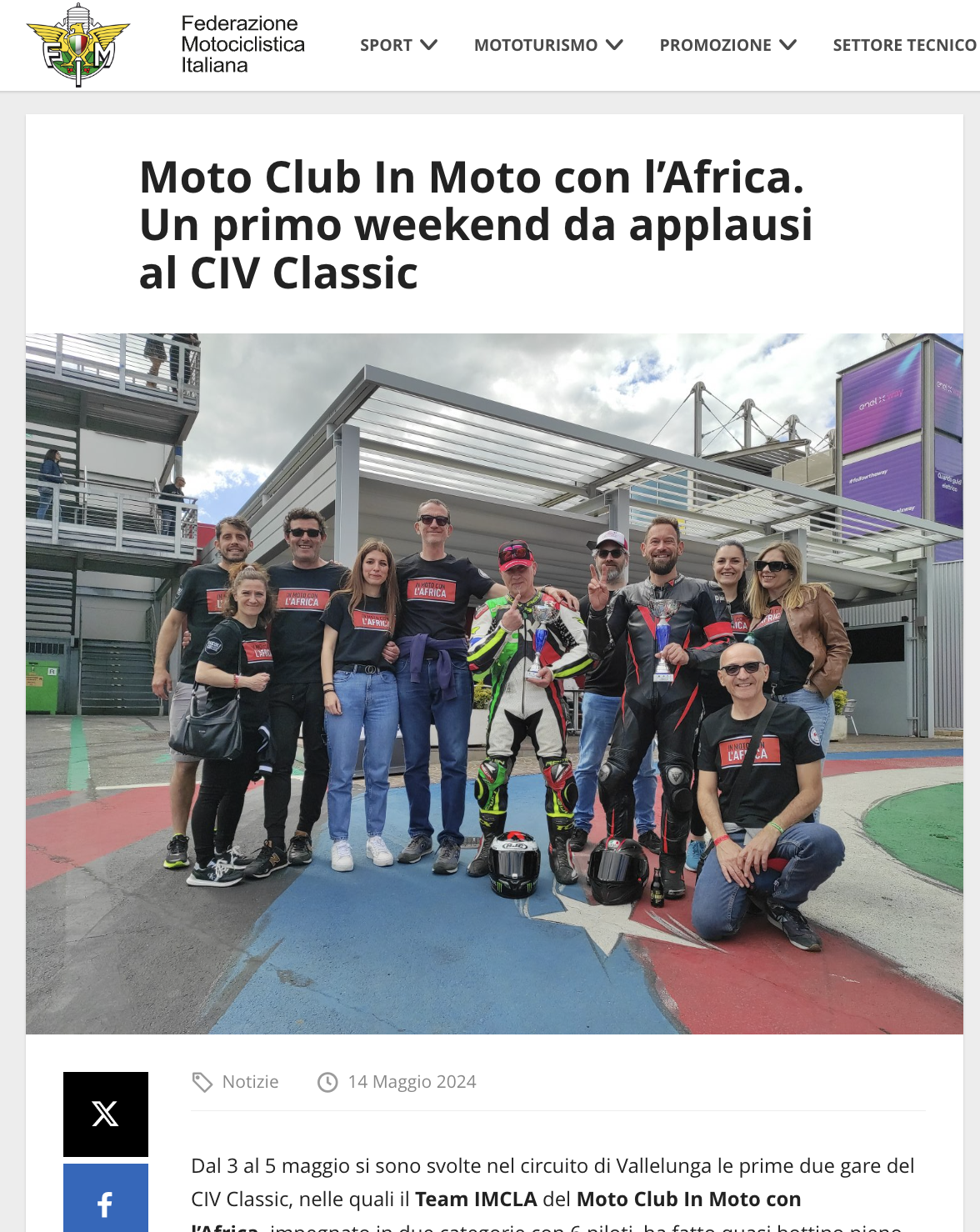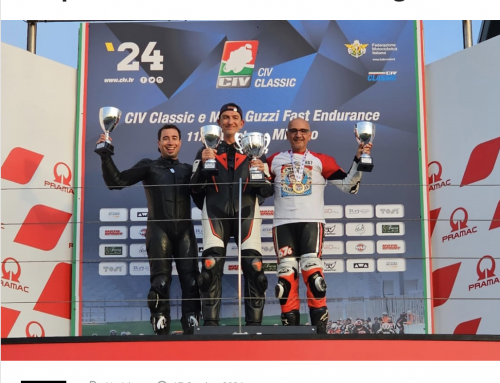L’Africa dei miei occhi e del mio cuore di Marco Visonà – Aprile 2020.
La povertà te la possono anche raccontare. Ti possono persino dire che la Sierra Leone è uno degli stati con il più alto tasso di mortalità infantile, con il più basso indice di sviluppo umano, con un PIL pro capite che non raggiunge i seicento euro all’ anno. Tutte queste cose te le possono ben spiegare. E tu puoi anche pensare di aver capito la situazione. Ma poi decidi di partire e ti rendi conto che eri distante anni luce dall’ aver compreso. Sì, perché la povertà non è fatta di numeri e di statistiche. La leggi sul volto della gente, la respiri, la vivi, te ne riempi i polmoni. Ed allora la musica cambia completamente. Questo è il racconto di alcuni episodi del viaggio in Sierra Leone che ho compiuto ad inizio anno con Medici con l’ Africa Cuamm e con i miei amici di In Moto con l’ Africa, che ne sostiene e supporta il lavoro, occupandosi di raccogliere fondi per i trasporti, soprattutto in moto. E’ però fondamentalmente uno spaccato del tortuoso percorso che ho fatto all’ interno delle pieghe più remote della mia anima e delle sue debolezze. E’ la testimonianza della iniziale sofferenza provata per la mia inadeguatezza e del senso di colpa per la mia condizione di privilegiato. Si è deciso di organizzare una Missione con partenza da Freetown, la capitale, per raggiungere poi la parte più remota del paese, nel distretto di Pujehun. Volevamo infatti renderci conto di persona e toccare il problema con mano, per poter ottimizzare ed indirizzare ilnostro lavoro. Il primo desiderio che si ha, appena arrivati in Sierra Leone, è quello di voler fuggire. La corrente elettrica è molto scarsa. L’ acqua di conseguenza. Tranne alcune strade principali che stanno costruendo società cinesi, la rete viaria è costituita prevalentemente da strade sterrate. Non esiste quasi niente di quello che noi diamo per scontato che debba esistere. La maggioranza della gente, soprattutto nelle zone periferiche, è decisamente malnutrita. Le case sono in maggioranza baracche, se si escludono alcuni palazzi della capitale, ad appannaggio degli occidentali. Molte abitazioni, soprattutto rurali, sono costruite con mattoni fatti di terra essiccata. Il clima è sgradevole. Un caldo umido nella migliore delle ipotesi. E poi, durante la stagione estiva, pioggia ed acqua torrenziale per mesi. Il sistema sanitario è precario, per usare un eufemismo. Una mamma su diciassette muore di parto. Gli ospedali esistenti sono sempre in affanno, con carenza cronica di tutto: personale, strumenti, medicine. In sintesi, quanto di più vicino alla rappresentazione che abbiamo dell’ inferno. E quindi è chiaro che la prima reazione sia quella di dire: non c’è niente da fare. Scusate il disturbo, come non detto, torniamo a casa. Ma poi vedi la gente. Guardi i loro occhi, pieni di travolgente vitalità. Osservi i loro sorrisi, nonostante tutto. Ed allora pensi che è vero che non hai capito niente. Ti rendi conto che devi solo ascoltare il tuo cuore. Avere la voglia di imparare, non di insegnare. E comincia quindi il tuo percorso interiore, che ti porterà ad individuare il tuo nuovo cammino. Dopo un viaggio durato quasi tutta la nostra prima giornata, siamo arrivati a Pujeun, passando per Bo. Siamo stati ospitati nella guest house adiacente all’ ospedale gestito direttamente da Medici con l’ Africa. E qui si verifica il primo fatto scatenante. Alla mattina vengo svegliato prima dal richiamo del muezzin e dopo da un poderoso canto gospel. Dopo essermi vestito, esco con Michele, mio compagno di stanza e di avventure da una vita. Il coro è quello della scuola femminile dall’ altra parte della strada. Una struttura semplice, aperta ai lati. Mi avvicino ad
una delle aperture e vengo letteralmente rapito. Il maestro stava motivando le ragazze, le stava incitando a non aver paura. Il tutto condito da canti e balli. E le ragazze sembravano quasi in estasi, con un continuo scuotimento di testa e spalle. Il docente ci vede e ci chiama. Si informa su chi fossimo e glielo spiego. Si rivolge alle scolare, dicendo loro che eravamo due cooperanti del Cuamm, lì per dare una mano a risolvere un po’ dei loro problemi. E poi mi da’ la parola. Ed io letteralmente non capisco più niente. Vengo sopraffatto dall’ emozione ed entro in una specie di trance mistica. E comincio un sermone. Mi vengono fuori frasi del tipo: “ sono io che devo ringraziare voi, perché mi state spiegando cosa vuol dire affrontare la vita “, “ voi siete il nostro futuro”, “noi crediamo in voi”, “la vostra forza sarà maggiore delle difficoltà”. Per finire poi con un perentorio “ God bless you all ! “. Saluto, mi giro e vedo Michele a bocca aperta, che mi dice: ”non pensavo tu fossi anche un predicatore…”. Non ne avevo la più pallida idea anch’io. Sapevo solo che mi mancava il respiro. Che avevo un nodo alla gola che non riuscivo a digerire. Che avrei avuto voglia di urlare a squarciagola. Secondo tappa della mia catarsi alcune ore dopo, all’ esterno del centro medico periferico di Gbondapi. Mi inginocchio a vedere due bimbe che stanno giocando a terra. Le osservo, mi sembrano proprio due belle bambine. Penso che potrebbero essere mie figlie o forse due nipotine. Nel frattempo si avvicina il medico olandese, direttore dell’ ospedale di Pujehun. Mi chiede: “ Come ti pare che stiano ?”. “Bene” rispondo. “ Guarda i capelli, gli occhi, il muco “ribatte. Morale: malnutrite ed una delle due con una cronica bronchite che chissà in cosa sarebbe sfociata. Altra pugnalata diritta al cuore e senso di impotenza. “Dio, se ci sei, dammi la forza di resistere !” Terzo episodio. Dopo due ore di navigazione fluviale, su una piccola barca a motore, arriviamo a Saame, un piccolo villaggio sperduto nel niente, dall’ altra sponda del fiume rispetto alla nostra di partenza. E qui succede l’impossibile. Quanto di più clamoroso avrei mai potuto pensare. Una fucilata di emozioni in pieno petto. Sbarcati, vengo letteralmente investito da una cinquantina di bimbi ululanti che vogliono toccarmi, darmi il cinque, letteralmente assalirmi. E quindi, anche in senso di difesa, inizio ad organizzare una serie di giochi per coinvolgerli tutti. Alzo una mano e loro anche. Ne alzo due ed i bimbi mi seguono. Bene proviamo man mano con qualcosa di più complesso. Alla fine si crea un’ atmosfera irreale fatta di canti, urla, salti. Tutti cercano di avere la loro parte nella storia, dove io sono il centro e loro mi gravitano attorno. Vengono poi richiamati all’ ordine. Devono ritornare nella loro capanna scuola. Resto solo e prosciugato. Mi domando perché abbiano scelto me per questa loro esplosione di calore umano. Mi rispondo che forse è dovuto alla mia fisicità, alla mia altezza di quasi due metri. Non avranno mai visto un uomo bianco così alto, mi dico. Ma mi convinco che sia un segno. Un segnale, che mi è arrivato chissà da dove, per tracciare il mio nuovo percorso. Altra voglia di piangere, ma non posso. C’è troppa gente che potrebbe vedermi…. Quarto capitolo. Ospedale materno PCMH di Freetown. Ci stanno spiegando come sono organizzati, le difficoltà di lavorare a volte senza acqua, con pochi posti letto, con una rianimazione frutto di una generosa donazione, ma insufficiente. Ci stanno raccontando della mancanza di bagni, delle problematiche di dover seguire molte più partorienti di quante si potrebbero. Poi arriva Ester, una dottoressa italiana che sta facendo sei mesi di specializzazione come rianimatrice. Ci dice che è arrivata da poco e ci racconta di come siano grandi le montagne da scalare. “Pensate – prosegue – che la settimana scorsa è entrata una mamma con una brutta emorragia”. “ Cerco di stabilizzarla, ma va in arresto cardiaco”. “ Chiedo un defibrillatore, ma non si trova. Dovrebbe essercene uno, ma nessuno sa dove sia. Forse è rotto, mi dicono”. “ Allora chiedo un po’ di adrenalina”. “Non c’è, mi rispondono”. Proseguendo ci domanda:” Sapete cosa abbiamo fatto ? “ No, rispondiamo. “ Ci siamo messe in cerchio, io e le infermiere, ed abbiamo iniziato a pregare…”. Mi aspettavo che il Signore le avesse dato una mano, ma non avevo il coraggio di interrogarla. “ E come è andata a finire ? “ chiede una voce dal capannello di persone che si era intanto formato. Risposta : “ Ha chiuso gli occhi ed è volata via !”. Le gambe hanno iniziato a tremarmi. Madre mia, dall’ alto dei cieli, dammi la forza di non svenire. Volo di rientro, vendetta di Montezuma. Notte passata fra il sedile ed il bagno. A casa di Michele mi aspettano le mie amate donne: mia moglie e mia figlia. Mi caricano in macchina per portarmi a casa e mi domandano come sia andata. Inizio a parlare, ma le parole si inceppano. Comincia a mancarmi il fiato. Inizio con un pianto a dirotto. Non riesco a continuare il mio racconto. Mi escono tutte le lacrime che avevo cacciato giù negli ultimi giorni. Un pianto liberatorio, la fine della mia sofferenza. Un paio d’ore più tardi mi sale la febbre e sono costretto a correre al Pronto Soccorso di Padova, per scongiurare che fosse malaria. Rispetto a quanto avevo visto in Africa, un paradiso. Continuo a fare i complimenti a tutti i medici, che mi prendono se non per pazzo, quantomeno per “singolare”. Loro non capiscono, io sì. Ho trovato la strada, finalmente mi rendo conto che è possibile cambiare il mondo. Sono diventato un visionario ? No, semplicemente ho realizzato quanto sia necessario che ognuno di noi si impegni a fare la propria parte. Piccola o grande che sia. Tante semplici azioni possono fare la differenza. Ogni vita salvata non è solo un decimale detratto dalle fredde statistiche. Ma una storia, una faccia, un sorriso, un abbraccio.
L’ Africa dei miei occhi e del mio cuore – Marco Visonà (scarica il pdf)